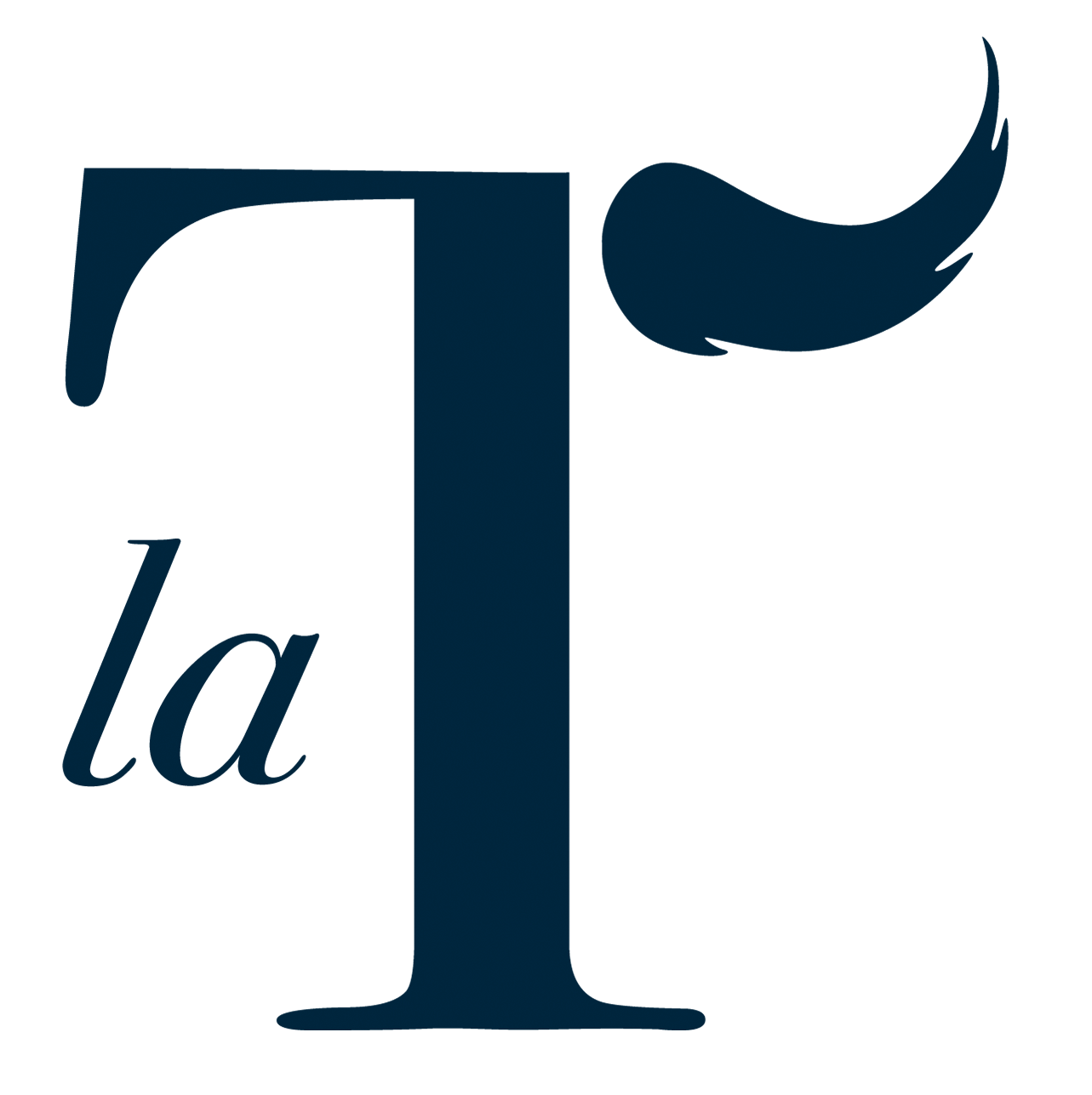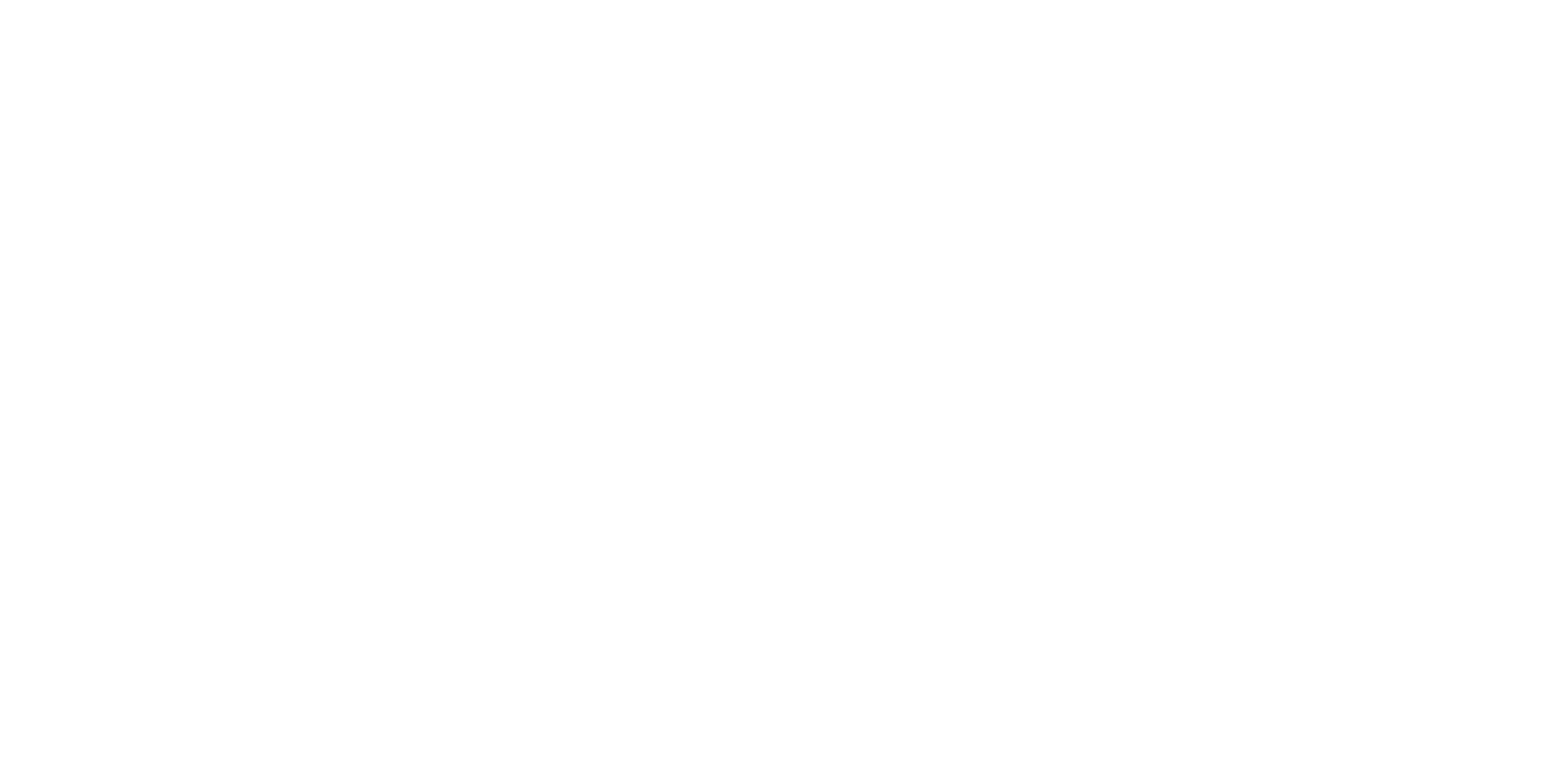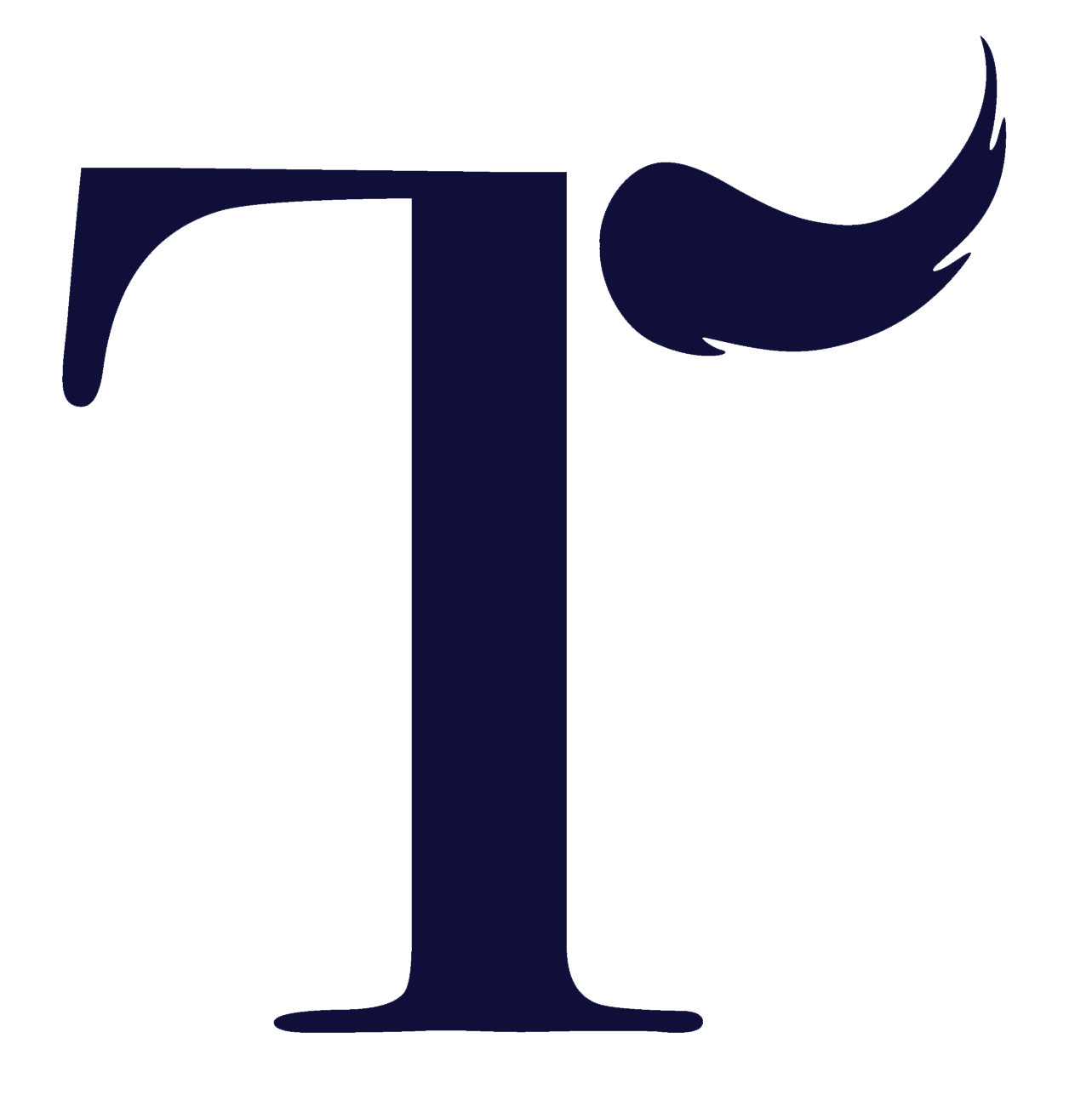Nel Concerto di Pasqua in Duomo pagine di grande pathos umano e religioso: Enrico Onofri dirige la Filarmonica Toscanini.

Nel Concerto di Pasqua pagine di grande pathos umano e religioso con lo Stabat Mater di Luigi Boccherini, la Sinfonia n.25 e la Musica funebre massonica di Mozart.
Enrico Onofri dirige la Filarmonica Toscanini. Mercoledì 16 aprile alle 20.30 Cattedrale a Parma
Un profondo senso del tragico, una inquietudine squisitamente umana e allo stesso tempo una richiesta urgente di stemperare tali sentimenti nella consolazione delle fede religiosa, pervadono le musiche che compongono il Concerto di Pasqua che si tiene in Cattedrale a Parma mercoledì 16 aprile alle 20.30 con la Filarmonica Toscanini diretta da Enrico Onofri. Il programma ruota attorno allo Stabat Mater composto da Luigi Boccherini su richiesta dell’Infante di Spagna, Don Luis, nel 1781 per organico cameristico poi ampliato nel 1800 per due soprani e un tenore, che in concerto saranno: Valentina Mastrangelo, Nikoletta Hertsak e Luigi Morassi. Completano due composizioni di Mozart cariche di umano pathos: la Sinfonia n.25 e la Musica funebre massonica.
Pagina si rara esecuzione lo Stabat di Boccherini esige in ossequio alla partitura che, nel contrappuntare la sequenza attribuita a Jacopone da Todi, una densa spiritualità, per esaltare il dolore straziante di Maria in lacrime, ai piedi della croce “dum pendebat Filius”: in questo senso l’autore raccomandava agli esecutori di mirare alla “pura semplicità ed esattezza”. I versi sono stati ripartiti dal compositore in undici distinte sezioni più un’introduzione e gli inserti strumentali si integrano perfettamente con le linee solistiche vocali, in un percorso che, tra cambi di atmosfera e indicazioni agogiche, mira al progressivo coinvolgimento emotivo con la drammatica scena descritta dal testo. A proposito delle due composizioni mozartiane: tenebrosa e inquieta è Sinfonia n.25 immersa in un’atmosfera da Sturm und Drang scritta a 17 anni mentre la Musica funebre massonica si sviluppa come una marcia solenne, permeata da un senso di antica grandezza. Fu eseguita la prima volta il 17 novembre dello stesso anno per commemorare la morte di due fratelli massoni (il duca Giorgio Augusto di Meclemburgo-Strelitz e il conte Franz Esterhazy von Galantha). Mozart applica qui un tempo di marcia (allusivo alla marcia funebre) a una cantus firmus gregoriano, Scrive Paumgartner: «La severa struttura formale, la scelta accurata e la trattazione degli strumenti, il singolare snodarsi della marcia solenne intorno alla melodia gregoriana, conferiscono a questo lavoro un senso di antica grandezza e gli assegnano un posto specialissimo nella produzione di Mozart».